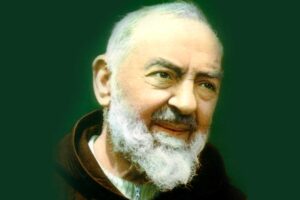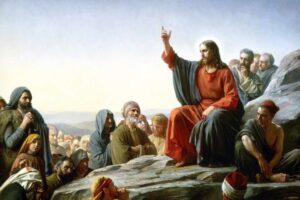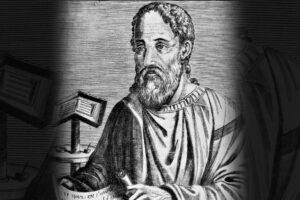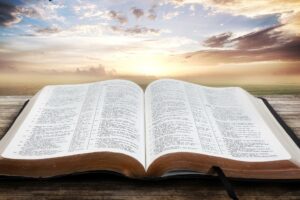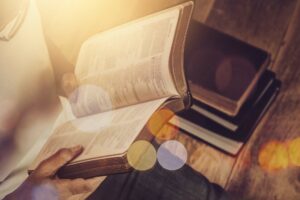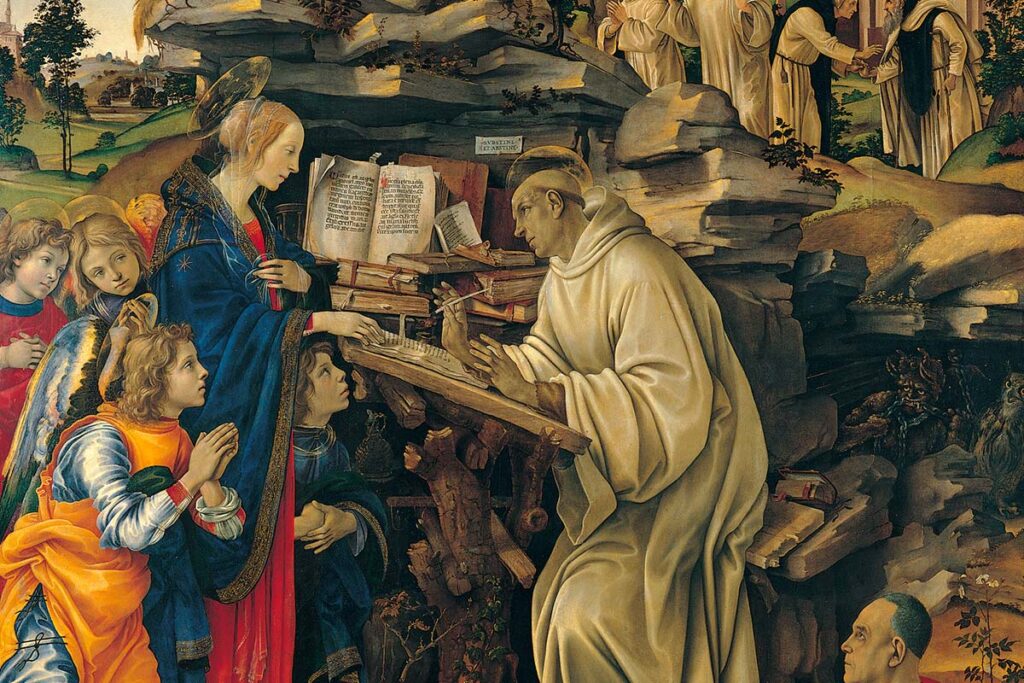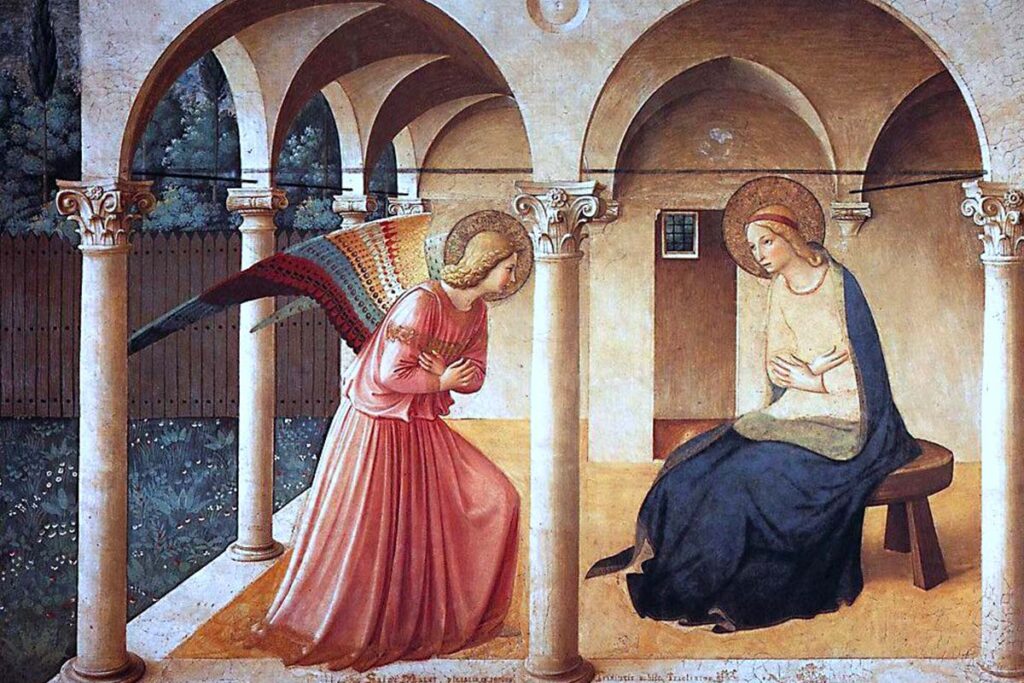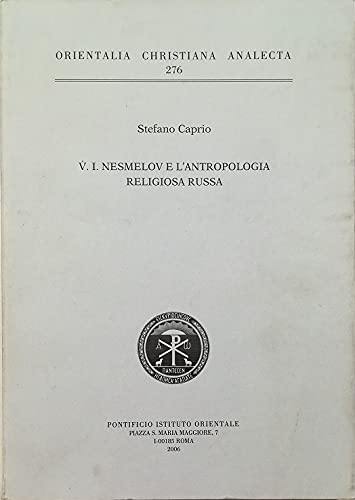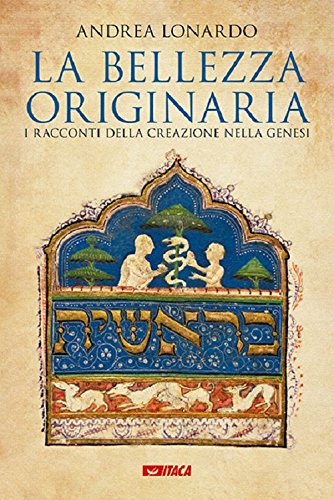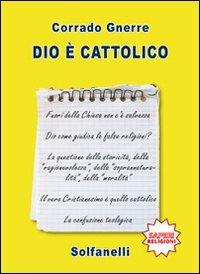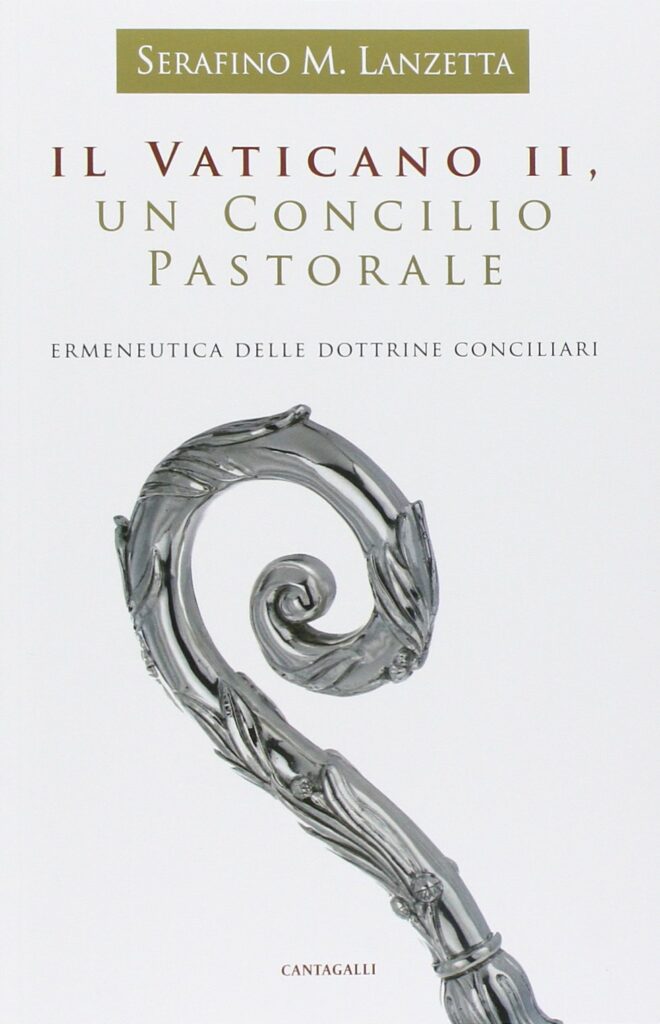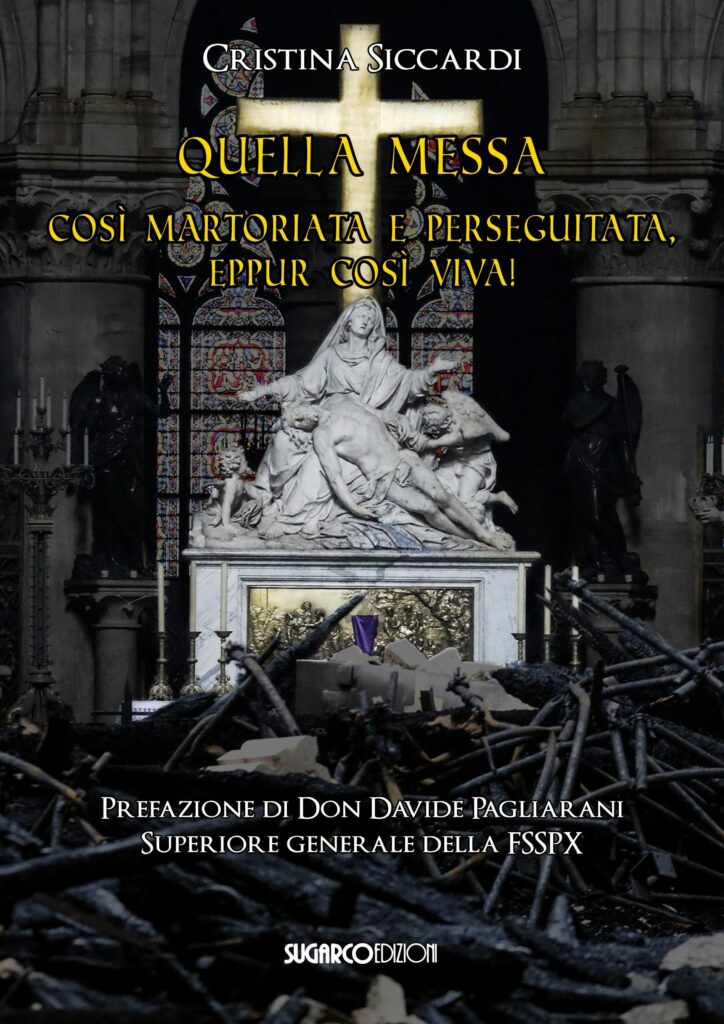Paganesimo e Cristianesimo, quali differenze?

Approfondire in un articolo le differenze che intercorrono tra paganesimo e cristianesimo è ovviamente impossibile. É però possibile offrirne una sintesi.
Va detto che c’è una sostanziale differenza tra paganesimo e cristianesimo; differenza da cui logicamente scaturiscono altre.
La differenza riguarda il modo di concepire il divino e quindi la spiegazione dell’antropogonia, cioè dell’esistere dell’uomo o – più semplicemente – come l’uomo sia stato generato dal divino stesso.
Sono costretto a generalizzare e quindi ad evitare tutta una serie di distinguo che pur sarebbero importanti, ma una categorizzazione a riguardo può essere molto utile.
Nel mondo pagano, tanto quello del contesto del Mediterraneo, quanto del Nord Europa e anche al di fuori dell’Europa stessa, il divino viene concepito come una realtà al di là del bene e del male. Si tratta di una concezione tipicamente gnostica e quindi che esprime un modo di concepire il divino in senso puramente volontaristico. Un divino arbitrario, capriccioso e pieno di contraddizioni.
La stessa, accentuata, diversificazione dei vari dèi, aventi tutti i difetti umani, anzi: difetti ancor più consistenti rispetto a quelli dell’uomo stesso, era nel paganesimo il riflesso della convinzione secondo cui nel divino albergasse la coesistenza (e quindi la contraddizione) tra il positivo e il negativo, tra ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, appunto: tra il bene e il male. Differenza enorme e sostanziale rispetto al Dio cristiano dove l’evidenza logica e filosofica esprime la costitutiva bontà del divino e, conseguenzialmente, la sua alterità rispetto a qualsiasi tipo di contraddizione.
Da questa sostanziale differenza – come dicevo – ne scaturiscono molteplici.
Mi limiterò a trattare quella sulla dignità della persona umana e sulla sua libertà.
Paganesimo e Cristianesimo: la dignità e la libertà della persona umana
Nel mondo pagano è assente un riconoscimento universale della dignità della persona umana.
Si prenda ad esempio l’istituto giuridico della schiavitù, che – di fatto – è presente in tutti i contesti precristiani, anche se con rapporti quantitativi diversi tra schiavi e liberi. Chiediamoci: perché la schiavitù era così universalmente presente? Per un motivo molto semplice. Se il divino ha generato l’uomo non per amore ma per servirsene, allora è legittimo che alcuni uomini possano servirsi di altri. Se il divino ha generato l’uomo come suo strumento, è giusto che l’uomo possa strumentalizzare un altro uomo.
Ma la natura ambigua del divino genera nel mondo pagano un’altra problematica conseguenza sul piano antropologico: l’assenza di una vera libertà, ovvero l’assenza di una libertà attraverso la quale l’uomo possa avere la capacità di essere davvero depositario del suo destino. Erodoto (famoso storico greco vissuto nel V secolo a.C.) parla di un divino brutale che non lascia spazio alla libertà. Fu l’invidia degli dèi che colpì Creso nell’affetto dell’unico figlio, perché aveva avuto il torto di ritenersi il più felice tra gli uomini. E fu sempre l’invidia degli dèi che abbatté Serse dalla gioia delle sue speranze, quando già si illudeva di avere in pugno la vittoria.
In tutte le civiltà precristiane, proprio a causa di questa mancanza di riconoscimento della libertà, si sviluppò una concezione ciclica della storia, chiaro segno dell’impossibilità da parte del singolo uomo di influire sul corso degli avvenimenti. Alessandro di Afrodisia, celebre commentatore di Aristotele, pur vivendo in un periodo già di forte decadenza, era convinto (e lo espresse bene nella sua opera intitolata “Sul Fato”) che il mondo fosse caratterizzato da una concatenazione di cause e di effetti assolutamente necessari e che questa concatenazione non potesse essere interrotta da alcun volere umano.
E così l’uomo pagano pativa un senso di oppressione che lo conduceva ad un atteggiamento negativo nei confronti della vita. Non è un caso che l’uomo greco abbia trovato il suo massimo riconoscimento esistenziale nel genere letterario della tragedia, mentre il grande capolavoro della letteratura della civiltà cristiana è una commedia: la Commedia di Dante.
Ma – dicevo – l’uomo pagano non solo avvertiva il peso esistenzialmente insopportabile di un senso d’invincibile impotenza (doveva ritenersi non libero), ma non poteva nemmeno condannare tutto ciò che di male avrebbe potuto capitargli.
Infatti, se si parte dalla convinzione che tutto è già deciso e che non c’è spazio per la libertà individuale, allora tutto ciò che è accade diviene automaticamente giusto, perché già deciso ed immodificabile. Un evento, se accadeva, significava che era stato voluto dal Destino, ma se era stato voluto dal Destino, significava che era buono, anche se si presentava come evento negativo o addirittura crudele. Secondo la nota leggenda, Atene doveva offrire periodicamente sette fanciulli e sette fanciulle a Minosse, re di Creta, perché li desse in pasto al Minotauro (un mostro dal corpo umano e dalla testa di toro che viveva confinato nell’inaccessibile labirinto di Dedalo). Ebbene, Minosse, per la mitologia greca, non era un personaggio negativo; anzi, per la sua giustizia, fu da Zeus eletto giudice nel regno degli Inferi. Ciò vuol dire che la storia è storia e basta. Il tentativo di modificare gli eventi può essere solo giustificato dal peso di viverli (Teseo arrivò ad uccidere il Minotauro), ma non dalla convinzione che ciò che accade nella storia sia ingiusto: Minosse dava in pasto al Minotauro i fanciulli inviati da Atene, eppure venne premiato da Zeus come giusto, il che vuol dire che secondo la mentalità greca tutto ciò che avviene nella storia, solo perché avviene, è di per sé giusto.
Sarà, invece, con il Cristianesimo che la storia verrà concepita come una sintesi tra la Provvidenza e le libere decisioni umane. La Provvidenza, ovvero l’intervento di Dio nella storia per aiutare l’uomo, non per decidere per lui o per sostituirsi a lui.