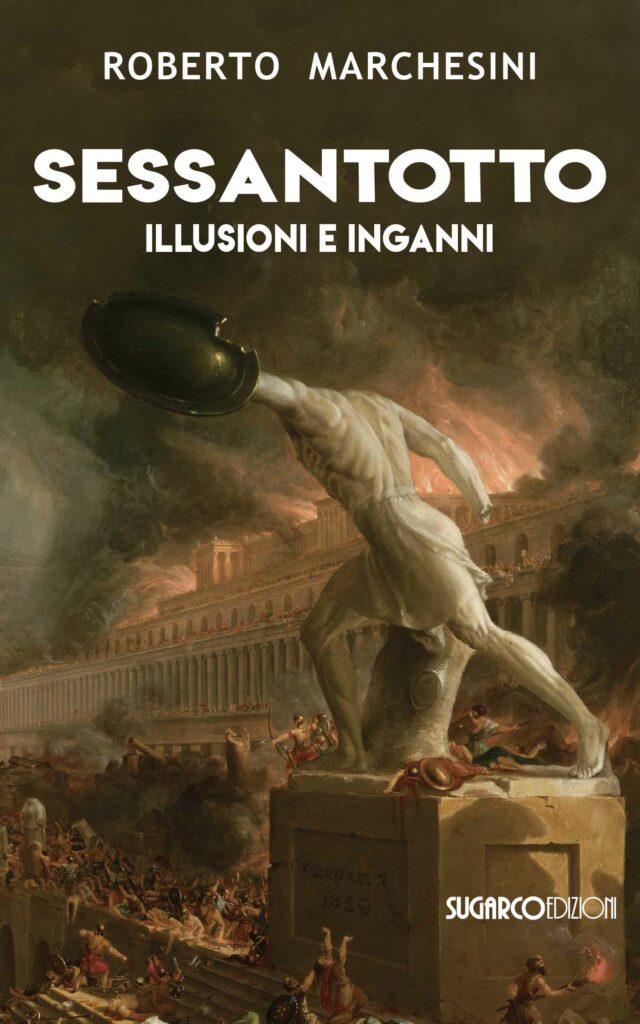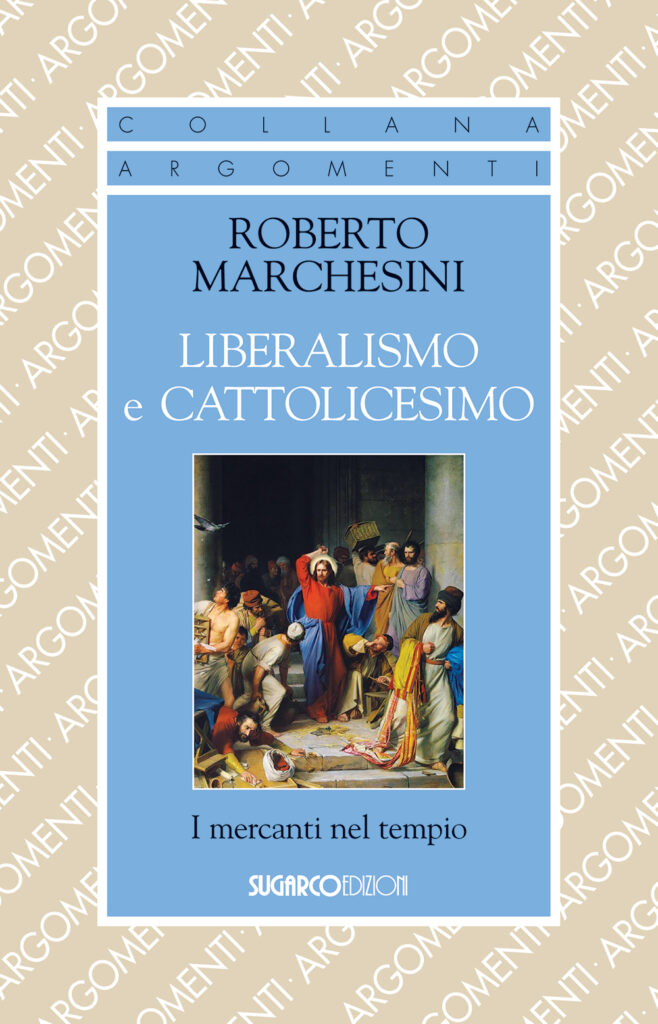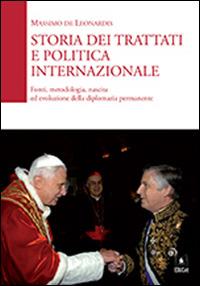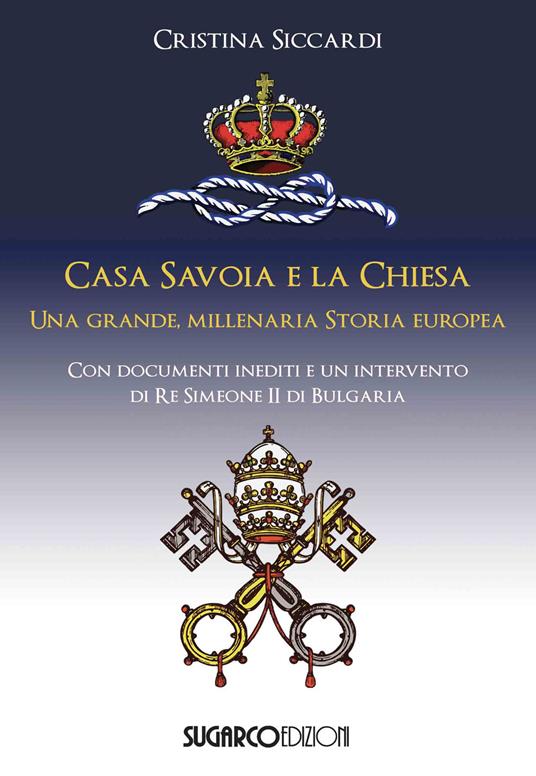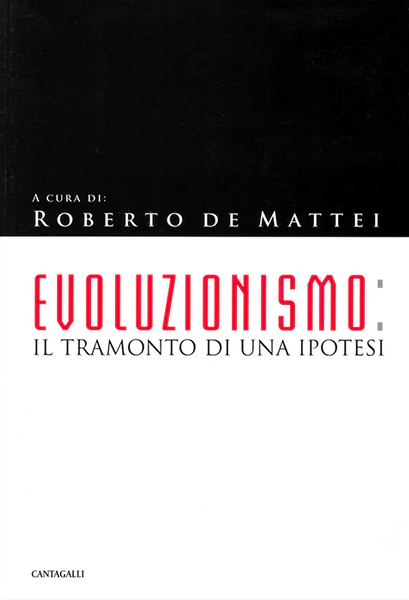Maremma, terra selvaggia e ricca di storia

Terra indomita e dalla bellezza incontaminata, la Maremma è il toponimo storico che individua l’area geografica affacciata sul Mar Tirreno fra la Toscana meridionale e il Lazio settentrionale: da Cecina a Corneto, secondo le parole di Dante Alighieri, che nel suo Inferno insiste sulla natura incolta e inospitale della zona, paragonandola alla selva dei suicidi. Ed, in effetti, la Maremma richiama ancora oggi alla mente le paludi malsane, che per lungo tempo ne occuparono i terreni, i briganti, che ne infestarono le contrade, l’ambiente non urbanizzato, che faceva da contraltare alla cosiddetta Toscana “colta” dei grandi centri medioevali e rinascimentali. Ma la Maremma ha rappresentato, nella storia, molto più di questo e, nel percorrerla, si possono oggi individuare le tracce dei popoli, che si sono avvicendati fra le colline della lunga striscia di terra, prospiciente il mare.
Maremma Pisana, Senese e Laziale
Comunemente suddivisa fra Maremma Pisana – situata nel territorio oggi tra Pisa e Livorno e anticamente posta sotto il dominio della nota Repubblica marinara –, Maremma Senese e Maremma Laziale, tra le province di Roma e Viterbo, la regione fu per secoli riunita sotto la cultura etrusca: il popolo italico vi fondò infatti importanti insediamenti, alcuni addirittura membri della Dodecapoli, l’insieme delle dodici città-stato maggiori, riunite secondo la tradizione in un’alleanza commerciale e militare. Fra queste, Populonia, Tarquinia e Vetulonia conservano ancora oggi i resti delle necropoli originarie, preservate da appositi siti archeologici, mentre a Roselle è stato riportato alla luce anche l’abitato romano: l’anfiteatro, le terme, una basilica paleocristiana risalente al V secolo dimostrano come fossero rimasti in vita diversi floridi centri economici pure dopo la conquista romana dell’Etruria.
La regione fu chiamata Maritima dai nuovi colonizzatori per la sua vicinanza alle coste, probabile origine del nome attuale, e molti sono i reperti, che testimoniano come tante città avessero conservato la propria vitalità nel passaggio fra le due dominazioni. La Maremma dunque offre allo storico un ricco terreno di ricerca ed è diventata un luogo da interrogare per meglio conoscere il passato della Penisola italiana, non solo antico, anche medioevale.
I diversi centri infatti, compresi fra i domini longobardi della Tuscia e lo Stato della Chiesa, conobbero alterne vicende e costituirono il fulcro del potere di importanti dinastie: spiccano i feudi degli Aldobrandeschi, che acquisirono un vasto potere, passando da conti a principi territoriali, e che diedero alla Chiesa uno dei pontefici più significativi dell’età medioevale. Ildebrando di Soana, cappellano di Gregorio VI e consigliere di Leone IX, elevato alla Cattedra dell’Apostolo nel 1073 col nome di Gregorio VII, dette avvio alla stagione di riforme e di scontri con il potere imperiale, che passerà alla storia come «lotta per le investiture».
Castelli e presidii
Nei secoli centrali del Medioevo, sorsero in Maremma numerosi incastellamenti, sviluppatisi in borghi e protetti da salde mura di cinta: alla casa degli Aldobrandeschi appartenne la rocca di Montemerano, al sommo di un colle abitato da ulivi e cipressi, che conserva la tipica fisionomia urbanistica del tempo; Capalbio, sotto giurisdizione abbaziale, mostra invece i ruderi di un imponente castello difensivo.
A partire dal XIII secolo, la Maremma centrale cadde progressivamente sotto il controllo della Repubblica di Siena e, dopo la definitiva conquista fiorentina della Toscana nel 1559, fu unita come quella pisana ai domini medicei.
Nel corso del Cinquecento, per far fronte agli attacchi dei pirati barbareschi che infestavano il Tirreno, le coste furono dotate di un complesso sistema difensivo formato da un’articolata serie di torri e fortificazioni in funzione antiturca, alcune costruite ex novo, altre ricavate da precedenti castelli. Nel 1557 si era inoltre costituito lo Stato dei Presidii sotto il controllo della Spagna, così chiamato proprio perché creato per scopi logistici e militari dall’unione dei presidii fortificati di Orbetello, Porto Santo Stefano e Talamone.
Tra il XVIII e il XIX secolo prese avvio la bonifica delle paludi maremmane ad opera di privati possidenti e dei Granduchi di Toscana, bonifica che verrà completata agli inizi del Novecento. Ciò consentì un aumento della popolazione residente ed un’estensione dei terreni coltivabili: l’immagine della Maremma incolta e abbandonata rimase così solo un’idea letteraria, lasciando il posto ad una terra ricca di fascino, ad opere d’arte ed a segni del passato.
FONTE: Radici Cristiane n. 160